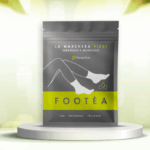Il diritto di abitazione rappresenta una delle forme di diritti reali di godimento disciplinate dal Codice Civile italiano e garantisce al titolare la facoltà di vivere nell’immobile, limitatamente al soddisfacimento delle esigenze proprie e della propria famiglia. Questo diritto si distingue dalla proprietà perché non consente, di regola, la vendita, la locazione, né l’alienazione totale dell’immobile. Può insorgere sia per disposizione testamentaria sia per accordi tra privati, spesso in ambito successorio o in seguito a separazione coniugale.
Cosa comporta il diritto di abitazione ai fini IMU
Uno degli aspetti meno conosciuti riguarda proprio il rapporto tra diritto di abitazione e IMU (Imposta Municipale Unica), imposta patrimoniale sul possesso di case e altri immobili. La normativa italiana stabilisce che il soggetto passivo di IMU non è necessariamente il proprietario dell’immobile, ma chiunque detenga un diritto reale su di esso, incluso dunque anche il titolare di un diritto di abitazione o di usufrutto. Secondo gli articoli 1022 e seguenti del Codice Civile, infatti, il titolare gode dell’immobile in modo esclusivo, assumendo gli stessi doveri previsti per il proprietario, per quanto riguarda il pagamento delle imposte.
Questa interpretazione è stata consolidata da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (depositata il 29 febbraio 2025), che ha precisato come l’obbligo tributario passi al titolare del diritto di abitazione purché il diritto sia stato formalizzato mediante scrittura privata registrata e ne sia dato tempestivo avviso al Comune.
Quando è davvero dovuta l’IMU
La situazione varia notevolmente a seconda delle caratteristiche dell’immobile e della sua destinazione:
- Chi detiene il diritto di abitazione in un immobile e vi risiede abitualmente, potrà beneficiare dell’esenzione IMU prevista per la prima casa, se rientra nelle categorie catastali da A2 a A7.
- L’esenzione non si applica per le cosiddette abitazioni di lusso, ovvero quelle appartenenti alle categorie A1, A8 e A9: in questi casi, il titolare è tenuto al pagamento dell’imposta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
- Se il titolare del diritto trasferisce la residenza altrove e l’immobile non è più “prima casa”, l’IMU diventa sempre dovuta.
Inoltre, coloro che godono del diritto di abitazione devono far fronte ad altri obblighi: oltre all’IMU, sono tenuti al pagamento della TARI (tassa sui rifiuti), delle spese condominiali e delle manutenzioni ordinarie, poiché sono considerati a tutti gli effetti utilizzatori dell’immobile.
Distinzione tra diritto di abitazione e altre ipotesi di uso
Dal punto di vista tributario, è importante differenziare il diritto di abitazione dall’usufrutto. Entrambi sono diritti reali che attribuiscono il possesso dell’immobile, ma l’usufruttuario può anche concedere la casa in locazione, mentre il titolare del diritto di abitazione la può utilizzare solo per sé e per la propria famiglia. Nel caso in cui il proprietario ceda l’uso dell’immobile a un terzo estraneo, senza concedere un diritto reale registrato, la responsabilità del pagamento IMU resta a suo carico. Invece, quando viene costituito formalmente un diritto di abitazione e comunicato agli enti competenti, ogni obbligo fiscale passa al titolare del diritto.
Questa distinzione fa sì che numerose attribuzioni di immobili in ambito familiare (ad esempio, dopo una separazione, quando la casa coniugale viene assegnata al coniuge non proprietario) siano soggette alla normativa sull’IMU relativa ai diritti reali. L’ex coniuge assegnatario, se il diritto è formalmente costituito e comunicato, è tenuto al pagamento dell’imposta anziché il proprietario.
La verità sulle detrazioni, le agevolazioni e le novità
La Legge di Bilancio degli ultimi anni ha introdotto alcune novità significative: per esempio, in caso di prima casa adibita ad abitazione principale, sono previste detrazioni anche a favore del titolare del diritto di abitazione. In presenza di figli a carico con età inferiore a 26 anni e residenti nell’immobile, si possono applicare ulteriori agevolazioni.
Il calcolo della base imponibile IMU resta invariato e si basa sul valore catastale dell’immobile, cui vanno applicate le aliquote stabilite dal Comune di competenza. Queste aliquote possono variare ogni anno attraverso apposita delibera dell’amministrazione comunale. Il versamento dell’IMU avviene generalmente in due rate, con scadenza fissata al 16 giugno e 16 dicembre.
Per comprendere in modo approfondito le varie tipologie di diritti reali e la loro incidenza sul pagamento dell’IMU è utile consultare la pagina dedicata ai diritti reali.
Documentazione e obblighi di comunicazione
Affinché il passaggio del pagamento IMU dal proprietario al titolare del diritto di abitazione sia valido davanti all’amministrazione fiscale, è indispensabile:
- Formalizzare il diritto tramite atto pubblico o scrittura privata registrata.
- Comunicare per tempo al Comune il transito del diritto, preferibilmente prima dell’anno fiscale di riferimento.
In caso di omissione, il Comune potrebbe continuare a considerare il proprietario come soggetto passivo d’imposta e le sanzioni potrebbero ricadere su quest’ultimo.
Implicazioni sulla dichiarazione dei redditi
Ai fini IRPEF, il titolare del diritto di abitazione deve inserire l’immobile nella dichiarazione dei redditi, comparando il proprio status a quello del proprietario. Quando l’immobile è adibito ad abitazione principale con residenza registrata, il titolare può dedurre dal reddito complessivo la rendita catastale, sempre che non si applichino le eccezioni stabilite per le categorie catastali di pregio.
Dubbi frequenti e chiarimenti pratici
Il panorama normativo dell’IMU è in continua evoluzione, ma la regola di base resta immutata: chi detiene un diritto reale di godimento sull’immobile è soggetto passivo dell’imposta, purché tale diritto sia regolarmente costituito e comunicato. Questo concetto allinea la situazione italiana alle normative europee di concorrenza fiscale. È importante distinguere il concetto di “possesso” in senso tecnico-giuridico, che differisce dal semplice utilizzo o dal fatto di risiedere nell’immobile senza titolo.
Le controversie più diffuse riguardano la mancata comunicazione al Comune della costituzione del diritto di abitazione o la corretta classificazione catastale dell’immobile. È bene dunque sempre accertarsi della categoria catastale e formalizzare ogni atto in modo trasparente.
Conclusioni operative
Il diritto di abitazione comporta impegni e responsabilità non sempre immediatamente evidenti. Ne consegue che chi vi abita a questo titolo deve:
- Verificare la regolare costituzione e comunicazione del proprio diritto.
- Accertare la categoria catastale del proprio immobile.
- Procedere al pagamento IMU e TARI nei tempi previsti.
- Detrarre le spese e le agevolazioni spettanti in dichiarazione dei redditi.
È fondamentale restare aggiornati sulle pronunce della Corte di Cassazione e sulle modifiche legislative che ogni anno possono incidere sulle detrazioni e sulle modalità di pagamento. Consultare periodicamente la voce IMU permette di orientarsi tra le novità del diritto tributario e di evitare spiacevoli sanzioni per errori nella dichiarazione fiscale.
In sintesi, chi vive in una casa con diritto di abitazione è direttamente responsabile del pagamento dell’IMU, se ricorrono determinati presupposti, e non può contare su un’esenzione automatica: la verità che pochi conoscono è che questa responsabilità spetta al titolare del diritto e non più al proprietario, sempre che la normativa sia rispettata e le comunicazioni siano regolarmente effettuate.